Luca è un
giornalista della Gazzetta di Bologna. È il 20 luglio 2001, l 'attenzione della
stampa è catalizzata dagli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante
il vertice G8 di Genova. In redazione arriva la notizia della morte di Carlo
Giuliani. Luca decide di partire per Genova, vuole vedere di persona cosa sta
succedendo. Alma è un'anarchica tedesca che ha partecipato agli scontri.
Sconvolta dalle violenze cui ha assistito, decide di occuparsi delle persone
disperse insieme a Marco, un organizzatore del Genoa Social Forum, e Franci,
una giovane avvocato del Genoa Legal forum. Nick è un manager che si interessa
di economia solidale, arrivato a Genova per seguire il seminario
dell’economista Susan George. Anselmo è un vecchio militante della CGIL e con i
suoi compagni pensionati ha preso parte ai cortei contro il G8. Etienne e
Cecile sono due anarchici francesi protagonisti delle devastazioni di quei
giorni. Bea e Ralf sono di passaggio e hanno deciso di riposarsi alla Diaz
prima di partire. Max, vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di Roma,
comanda il VII nucleo e non vede l'ora di tornare a casa da sua moglie e sua
figlia.Luca, Alma, Nick, Anselmo, Etienne, Marco e centinaia di altre persone
incrociano i loro destini la notte del 21 luglio 2001.
REGIA: Daniele
Vicari
SCENEGGIATURA: Daniele Vicari, Laura Paolucci
ATTORI: Elio
Germano, Claudio Santamaria, Rolando Ravello, Aylin Prandi, Alessandro Roja, Monica
Birladeanu, Jennifer Ulrich, Renato Scarpa, Davide Iacopini, Paolo Calabresi, Fabrizio
Rongione, Ignazio Oliva
FOTOGRAFIA: Gherardo
Gossi
MONTAGGIO: Benni
Atria
MUSICHE: Teho
Teardo
Recensione di Federico Gironi
Su una cosa
dovrebbero tutti essere d’accordo, indipendentemente dagli schieramenti
politici o cinematografici: che quanto accaduto a Genova durante il G8 del
2001, e in particolare alla scuola Diaz e nella caserma di
Bolzaneto, rappresenta ancora un ingombrante e vergognoso rimosso nella coscienza collettiva del nostro paese.
Bolzaneto, rappresenta ancora un ingombrante e vergognoso rimosso nella coscienza collettiva del nostro paese.
Raccontare quei
fatti al cinema, però, tendeva più di una trappola. E bisogna rendere atto a Daniele Vicari di
averle evitate pressoché tutte in un film di grande impatto emotivo.
Perché Diaz, prima di ogni
altra cosa, e soprattutto prima di essere un pamphlet, un volantino di
rivendicazione, è un film.
Un film che ha
voluto trovare prima di tutto nel cinema, nella struttura narrativa e nelle
dinamiche di genere, e poi nei dati fattuali estrapolati dagli atti
processuali, fondamenta solide abbastanza da poter resistere alle polemiche e
alle partigianerie.
Se poi quello di
Vicari è un film militante, lo è in forme decisamente insolite per la
tradizione del cinema italiano socialmente e politicamente impegnato: la sua
militanza non è figlia infatti di una partigianeria politica, ma di un sincero
e appassionato afflato democratico, e soprattutto rifugge ogni volontà più
direttamente accusatoria e dietrologica, facendosi documento (e non
documentario) il più possibile (s)oggettivo.
Il racconto polifonico su cui si basa Diaz ha una funzione diretta ed esplicita: quella di moltiplicare i punti di vista, le opinioni, e quindi a cercare una verità, per quanto personale, nella complessità.
Ma Vicari non adotta (solo) uno stile para-documentaristico, elaborando i dati fattuali e ricercando l’astrazione del e nel genere: ecco che allora questa terribile narrazione collettiva, dove gli sguardi e le voci (le lingue) si sovrappongono confuse e convulse, fanno del film un racconto allucinante e onirico.
Vicari non si nasconde dietro un dito, non nega gli errori nel movimento e non demonizza aprioristicamente le forze dell’ordine. Si prende le sue responsabilità e azzarda anche narrativizzazioni rischiose ma meritevoli, rifugge la retorica e rimane attaccato ai volti (e ai corpi) dei suoi protagonisti, lasciando che l’intrecciarsi delle loro storie e dei loro sguardi si snodi come un tesissimo incubo sotto gli occhi degli spettatori.
In questo quadro, è quasi ingeneroso, ma necessario, sottolineare come nei pochissimi momenti dove la sceneggiatura si fa sentire di più, in bocca a questo o a quell’attore, la nota suoni aspra e stonata.
Ma Diaz è comunque cinema intenso, doloroso e potente. Straziante nel racconto di una violenza riguardo la quale, alcune volte, Vicari si è intelligentemente censurato.
Opprimente e chiuso in sé stesso, senza vie d’uscita: un tunnel, come quello imboccato dal torpedone dei reduci alla fine del film.
Un grido assordante, rabbioso, ma in un certo senso muto: metaforicamente parallelo al senso di mani legate e d’impotenza di allora e di oggi e al colpevole silenzio di istituzioni che avrebbero dovuto avere il coraggio di parlare.
Non una denuncia, ma una testimonianza dell’orrore del reale.
Il racconto polifonico su cui si basa Diaz ha una funzione diretta ed esplicita: quella di moltiplicare i punti di vista, le opinioni, e quindi a cercare una verità, per quanto personale, nella complessità.
Ma Vicari non adotta (solo) uno stile para-documentaristico, elaborando i dati fattuali e ricercando l’astrazione del e nel genere: ecco che allora questa terribile narrazione collettiva, dove gli sguardi e le voci (le lingue) si sovrappongono confuse e convulse, fanno del film un racconto allucinante e onirico.
Vicari non si nasconde dietro un dito, non nega gli errori nel movimento e non demonizza aprioristicamente le forze dell’ordine. Si prende le sue responsabilità e azzarda anche narrativizzazioni rischiose ma meritevoli, rifugge la retorica e rimane attaccato ai volti (e ai corpi) dei suoi protagonisti, lasciando che l’intrecciarsi delle loro storie e dei loro sguardi si snodi come un tesissimo incubo sotto gli occhi degli spettatori.
In questo quadro, è quasi ingeneroso, ma necessario, sottolineare come nei pochissimi momenti dove la sceneggiatura si fa sentire di più, in bocca a questo o a quell’attore, la nota suoni aspra e stonata.
Ma Diaz è comunque cinema intenso, doloroso e potente. Straziante nel racconto di una violenza riguardo la quale, alcune volte, Vicari si è intelligentemente censurato.
Opprimente e chiuso in sé stesso, senza vie d’uscita: un tunnel, come quello imboccato dal torpedone dei reduci alla fine del film.
Un grido assordante, rabbioso, ma in un certo senso muto: metaforicamente parallelo al senso di mani legate e d’impotenza di allora e di oggi e al colpevole silenzio di istituzioni che avrebbero dovuto avere il coraggio di parlare.
Non una denuncia, ma una testimonianza dell’orrore del reale.
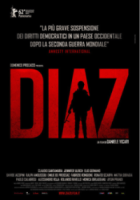
Nessun commento:
Posta un commento